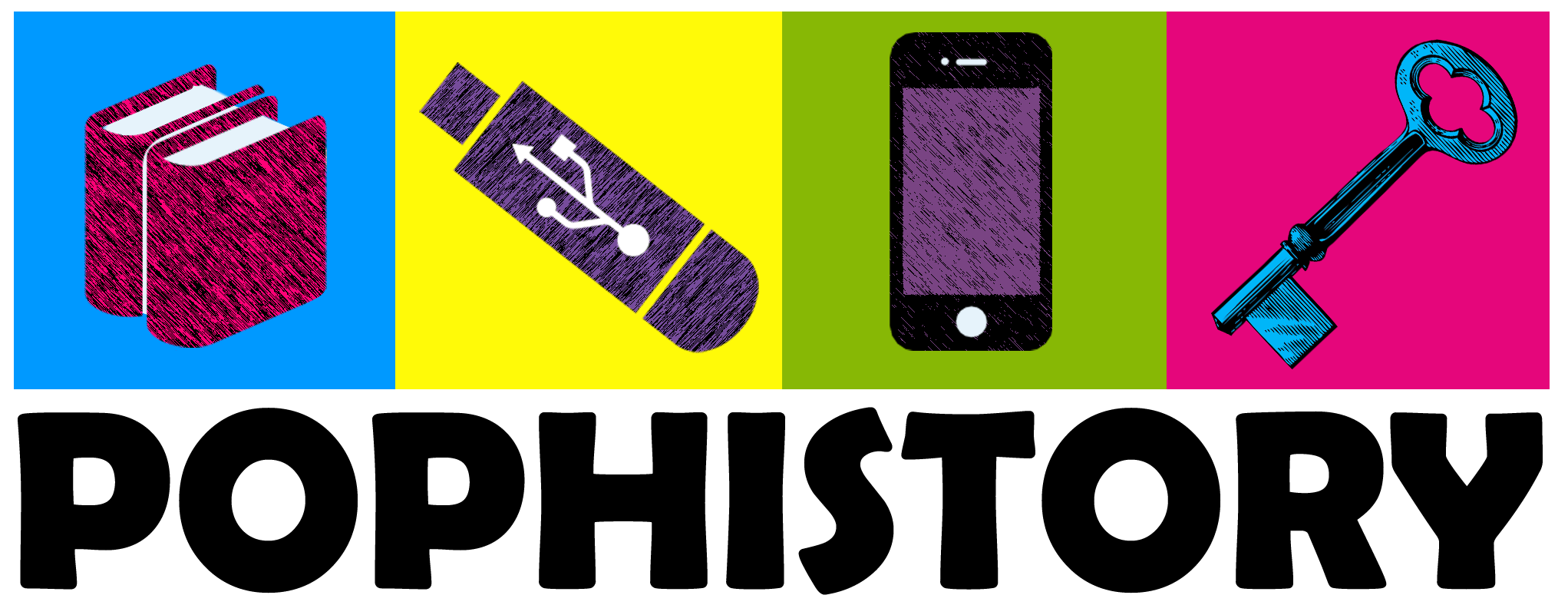Il Giardino Jacquard
di Gian Luca Gonzato
Alla scoperta del Giardino Jacquard
A Schio, in provincia di Vicenza, è possibile incontrare un luogo speciale nonché uno dei primi giardini aziendali mai realizzati in Italia: il Giardino Jacquard. Costruito tra il 1859 e il 1878[1] e antistante il monumentale portale d’ingresso del Lanificio Rossi,[2] il Giardino Jacquard deve il nome a Joseph Marie Jacquard[3] ed è una realizzazione tardo romantica di stile eclettico,[4] ad opera dell’architetto Antonio Caregaro Negrin (Vicenza, 1821 – Vicenza 1898) su commissione dell’industriale Alessandro Rossi (Schio, 1819 – Santorso 1898). Si sviluppa su un’area di circa 5000 metri quadrati, in parte in territorio pianeggiante e in parte lungo il lato di un colle, e si articola in spazi diversi tra loro. Solo per citarne alcuni: un ninfeo, un sistema di grotte e un giardino pensile. Al netto di queste indubbie bellezze paesaggistiche, perché vale la pena visitare oggi il giardino Jacquard? Perché, insomma, è un Place to Be Pop?
Il sito storico come chiave di accesso alla visione della committenza
Ad un primo incontro il Giardino Jacquard potrebbe sembrare una realizzazione inusuale per il contesto in cui è inserito. La sua entrata è frontale al monumentale portale d’ingresso al Lanificio Rossi (Figura A), che conduce al piazzale dominato dalla celebre Fabbrica Alta (realizzata tra il 1862 e il 1863 su disegno dell’architetto belga Auguste Vivroux). La strada che separa i due ingressi è Via Pasubio, che immette rapidamente nel centro storico di Schio. Retrostante il Giardino, infine, si trova la Chiesetta di San Rocco (il cui nucleo originario risale alla fine del Cinquecento). Insomma, un’oasi verde che si pone come elemento eccentrico nel contesto produttivo e nello spazio fortemente urbanizzato in cui è inserito. Il Giardino, però, non è un ambiente verde qualsiasi, tutt’altro. Al suo interno si può ammirare una grande varietà floreale ed arborea. Si possono trovare una Sequoia Sempervirens, un Cipresso del Portogallo, un Taxus Baccata e una Magnolia Soulangiana,[5] solo a titolo d’esempio. Oltre a ciò, il Giardino ospita una serra a esedra (Figura B), oggi in stato di abbandono ma che all’epoca conteneva orchidee,[6] un fiore tanto caro ad Alessandro Rossi. Una tale ricchezza floreale e arborea si può comprendere solo considerando la visione dello stesso Rossi il cui scopo era di portare equilibrio nella vita dei suoi operai, integrando all’attività lavorativa in fabbrica un contatto con la natura in uno spazio, come vedremo tra poco, che ospitava anche strutture con funzioni educative. La volontà di tutelare questo equilibrio si può, allo stesso modo, rintracciare nella prima progettualità riguardante il “Nuovo Quartiere Operaio” di Schio (spazio che doveva accogliere i lavoratori del Lanificio le cui abitazioni, secondo l’idea originale, dovevano essere inserite in un contesto naturale formato da aiuole, orti e giardini).[7] Il Giardino, quindi, rappresenta e concretizza la visione di Alessandro Rossi ed entrandovi in contatto è possibile avvicinare alcuni dei principi dell’industriale, i quali si ripresentano poi in altre progettualità e contesti.
Le architetture come spazi di memorie
Visitando il Giardino, poi, è possibile avvicinare spazi e strutture che, nel corso dei lavori della sua realizzazione, hanno più volte cambiato funzione e destinazione d’uso. Un esempio tra tutti: il Teatro Jacquard (Figura C). La struttura, posta sulla destra rispetto all’entrata, prima del 1859 era adibita a magazzino lane, casa del custode e stalla; successivamente divenne un centro culturale (ospitava infatti una biblioteca e un caffè) e dal 1869 i due piani superiori furono adibiti a Teatro. Inoltre, la facciata dell’edificio è anche arricchita di 12 medaglioni di cotto (ad opera dello scultore G.B. Boni) che raffigurano alcune delle più importanti personalità che nel corso dei secoli hanno contribuito alla crescita di Schio.[8] Sulla sinistra rispetto all’entrata, è presente l’attuale tettoia degli operai (Figura D). La struttura, realizzata nel 1878 dall’ingegnere Pergameni, fu costruita nel luogo dove prima era situato una parte del settecentesco opificio di Nicolò Tron (ceduto prima alla famiglia Rubini e in seguito ai Rossi). Questi luoghi hanno dunque una memoria e decostruendo la loro storia è possibile avvicinare i contesti sociali e culturali del passato, nei siti dove questi presero forma e si svilupparono. Restituire le potenzialità dei luoghi storici alla cittadinanza può certamente stimolare sensibilità e buone pratiche di conservazione del patrimonio culturale.
Il contatto con il patrimonio come strumento di riflessione
Come detto, all’interno del Giardino si possono trovare spazi un tempo adibiti a ruoli educativi. Lo si è accennato poc’anzi; il Teatro Jacquard, per esempio, ospitava, oltre ad un teatro, una biblioteca, un caffè e una scuola dove gli operai potevano recarsi per imparare a leggere e scrivere. Inoltre, il Teatro poteva ospitare fino a 600 persone in una loggia a ferro di cavallo che orientava l’attenzione degli spettatori verso la scena, decorata da motivi floreali. Il contatto con questa struttura, e con le diverse attività in essa ospitate, può stimolare nei visitatori riflessioni in merito alle differenze che dividono il passato dal presente, relativamente a un modo di intendere la cultura aziendale. In particolare, visitando il giardino si evince il tentativo di Alessandro Rossi di costruire un dopolavoro, cioè un’unione di spazi e luoghi di aggregazione dove gli operai potessero riunirsi dopo l’attività lavorativa di fabbrica.[9]
Perché dunque visitare il Giardino Jacquard? Perché può certamente stimolare nella cittadinanza attenzioni e sensibilità che inducano buone pratiche di conservazione e tutela del patrimonio culturale.
Note:
[1] Per un prospetto storico del Giardino si veda: Bernardetta Ricatti Tavone, Antonio Caregaro Negrin Architetto-Urbanista di A. Rossi in Schio e Alessandro Rossi. Imprenditorialità, politica, cultura e paesaggi sociali del secondo Ottocento (a cura di G.L. Fontana), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985, pp. 687-730, pp. 691-695;
[2] Per una sommaria cronologia delle principali tappe nello sviluppo dell’azienda si visioni la categoria milestone presente nel sito ufficiale della Lanerossi: https://lanerossi.com/pages/la-nostra-storia [consultato il 30 giugno 2025]. L’attività del Lanificio fu tanto rilevante che Schio, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, venne nota come la “Manchester d’Italia”; questa memoria è ancora viva nella comunità cittadina e annualmente è celebrata con un’apposita rievocazione. Si veda, per esempio, l’articolo di VicenzaToday per l’evento del 2023: https://www.vicenzatoday.it/eventi/schio-la-manchester-d-italia-rievocazione-storica-della-citta-agli-inizi-del-900.html#:~:text=Un%20evento%20che%20riporter%C3%A0%20alla,industriale%20di%20inizio%20XX%20secolo. [consultato il 30 giugno 2025];
[3] Inventore di una macchina che, applicata ai telai, rivoluzionò la tessitura. Per approfondimenti si visioni la voce biografica dell’Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/joseph-marie-jacquard_(Enciclopedia-Italiana)/ [consultato il 30 giugno 2025];
[4] L’ecclettismo architettonico è stato definito come “la combinazione nello stesso edificio di elementi tratti da vari stili storici”. Si veda: https://www.treccani.it/vocabolario/eclettismo/ [consultato il 29 giugno 2025];
[5] Per una agevole panoramica sulla diversità floreale ed arborea ivi presente si consiglia di visionare la guida che VisitSchio ha realizzato sul Giardino Jacquard: https://www.grandigiardini.it/_file/281_it_3-cartoguida_gj_2019.pdf;
[6] La memoria delle orchidee è ancora molto viva. Annualmente e nel mese di settembre, infatti, il Giardino ospita una mostra dedicata a questo particolare fiore. Di seguito la locandina relativa all’evento del 2024: https://orchideegiardinojacquard.weebly.com/ [consultato il 29 giugno 2025];
[7] Il progetto originale (del 1872 e ad opera di Antonio Caregaro Negrin) si ispira infatti al modello delle città-giardino. Ragioni di natura funzionale, però, imposero successivamente altri disegni. Per un prospetto storico delle diverse progettualità relative al Nuovo Quartiere Operaio si veda: Renzo Marchesini, Le società di Alessandro Rossi e il “Nuovo Quartiere” di Schio in Schio e Alessandro Rossi. Imprenditorialità, politica, cultura e paesaggi sociali del secondo Ottocento (a cura di G.L. Fontana), cit., pp. 319-358;
[8] Per approfondimenti sui personaggi presenti nei medaglioni si rimanda a: Edoardo Luigi Ghiotto, I dodici illustri del Giardino Jacquard, Schio, Menin, 2011;
[9] Tra il 1927 e il 1937 nel Comune di Valdagno (cittadina vicina a Schio) Gaetano Marzotto Jr realizzerà la “Città Sociale”, o “Città dell’Armonia”, dove rilevante importanza fu data a strutture che potevano ospitare attività per il dopolavoro. Sulla “Città Sociale” si veda: Giorgio Roverato, Valdagno e la “Città Sociale” di Gaetano Marzotto JR: tra utopia conservatrice e moderno welfare aziendale in “Annali di storia dell’Impresa”, 13/2002. URL: https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/xART_Marzotto_Valdagno.pdf [consultato il 1 luglio 2025];